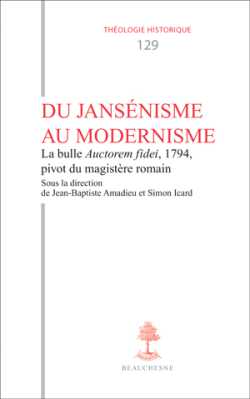L’opera collettanea Du Jansenisme au Modernisme. La bulle «Auctorem fidei» (1794), pivot du magistère romain è il frutto di un simposio di studiosi tenuto sotto la direzione di Jean-Baptiste Amadieu e Simon Icard. Dopo una prefazione curata dagli stessi Amadieu e Icard (9–13), il testo raccoglie gli scritti di sette autori e un’ampia ed approfondita conclusione di Philippe Boutry (227–236).
Il simposio ha avuto come oggetto di studio la bolla papale Auctorem Fidei, emanata il 28 agosto 1794 da Pio VI, che condannava 85 proposizioni contenute negli atti del sinodo diocesano di Pistoia del 1786, voluto e presieduto dal vescovo di Pistoia e Prato Scipione de’ Ricci. Il testo della bolla rimane poco conosciuto nella storiografia, sebbene ad esso siano stati dedicati studi da parte di Philippe Boutry e di Pietro Stella. Gli autori per offrire i loro contributi hanno cercato sostanzialmente di rispondere a due domande: quali sono le origini, il posto e la portata della bolla Auctorem Fidei nella storia lunga del giansenismo? In quale modo questo testo costituisce il primo passo nell’analisi e nella condanna degli errori moderni? È in un ampio raggio cronologico dato dal tempo che precede l’Auctorem Fidei e che segue la sua composizione che si può comprendere tale documento magisteriale. Essa infatti è considerata spesso come l’ultimo documento contro il giansenismo; di fatto – ed è questo che emerge dal volume – la bolla sorpassa la semplice questione del giansenismo e del sinodo di Pistoia ed è piuttosto un anello di congiunzione tra i documenti papali del XVIII secolo e la Mirari vos di Gregorio XVI. Auctorem fidei si presenta come un documento di riferimento nella elaborazione teologica intransigente del XIX secolo che ha nel Sillabo prima e nella Pascendi poi l’espressione più alta del magistero papale nella condanna degli «errori moderni».
Gli interventi sono aperti da Simon Icard, «Un fil rouge du jansenisme: l’obscurcissement général de la vérité» (15–28), che presenta la tesi dell’«oscuramento» delle verità nella Chiesa (la Chiesa necessità di un profondo rinnovamento nel vertice e nelle membra al fine di ritrovare la luce che era tipica della Chiesa originaria) che è ripresa nel sinodo di Pistoia e che l’autore mostra essere il «filo rosso del giansenismo». Tale tesi per la teologia romana metteva in crisi un dato fondamentale: la Chiesa come corpus sotto l’autorità del papa non poteva cadere nell’oscurità.
L’intervento di Gérard Pelletier, «Constitution dogmatique et contexte historique: regards croisés sur ‹Auctorem fidei›» (87–112), mostra la storia del testo «Auctorem fidei» che venne formandosi attraverso tre congregazioni romane apposite volute da Pio VI. Il papa all’inizio – la prima congregazione è del 18 dicembre 1788 – pensava ad un sinodo italiano, ma ciò fu impedito da motivi politici. Lungo lo svolgersi delle tre congregazioni, fino al 1794, la situazione venne ad arricchirsi di pubblicazioni di testi contro il sinodo e di fatti politici, soprattutto dall’incalzare della rivoluzione francese e dalla costituzione civile del clero, che condizionarono la sua composizione. L’autore fa comunque osservare che, sebbene il testo sia stato condizionato da fatti storici, i suoi compositori riuscirono a realizzare un documento magisteriale che ha superato la contingenza storica. La Auctorem fidei stabilisce infatti dei principi fermi a livello teologico che, passando per l’intransigentismo, giungono fino ad oggi.
L’intervento di Jean-Baptiste Amadieu, «Les usages d’‹Auctorem fidei› dans les censures littéraires de l’Index au XIX siècle» (201–226), mostra come la bolla, con la condanna della tesi dell’oscuramento della verità, ponesse al sicuro la Chiesa sul piano dottrinale e divenisse un perno per future condanne. Offre come esempio le condanne dell’Indice, nel XIX secolo, a tutti gli autori di opere letterarie che potevano allontanarsi dal magistero di Roma: i giansenisti, e coloro che erano portatori di una religiosità romantica o che rivendicavano il rinnovamento del Cristianesimo in una accezione che potesse ricordare la tesi dell’«oscuramento» delle verità.
Gli interventi riguardano gli effetti della bolla in Francia, ma anche quelli nel contesto politico, culturale e religioso dei diversi stati della penisola e nella stessa Roma.
In appendice è offerto il testo della bolla Auctorem fidei (237–288), cui segue la bibliografia (289–310).
Questo libro, con un’accurata analisi della Auctorem fidei, si presenta come una buona lettura per chi vuole approfondire la tematica di giansenismo, intransigentismo, magistero papale. Inoltre, la volontà di analizzare un testo di ampia portata teologica nel contesto dato dalla sua preparazione e nella sua influenza sul futuro della teologia e della vita della Chiesa, contribuisce a dare delle indicazioni di metodo per ulteriori ricerche.
Zitierweise:
Belluomini, Flavio: Rezension zu: Amadieu, Jean-Baptiste; Icard, Simon (Eds.): Du Jansenisme au Modernisme. La bulle «Auctorem fidei» (1794), pivot du magistère romain (Théologie Historique 129), Paris 2020. Zuerst erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Religions- und Kulturgeschichte, Vol. 117, 2023, S. 423-424. Online: https://doi.org/10.24894/2673-3641.00155.